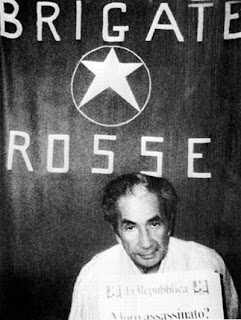Nimier, parigino di Neuilly-sur-seine, «cattolico bretone», come amava presentarsi con una punta di vanità, discendente dell’antica casata dei conti de la Perrière, sentiva l’esigenza di dover recuperare il tempo perso, avvertiva come una imperdonabile colpa l’essere nato “soltanto” il 31 ottobre 1925, troppo tardi per essere vicino ai confrères collabos, ai vinti, agli ultras maudit, a coloro che in virtù della loro militanza nella collaborazione vennero poi sistematicamente emarginati dal mondo letterario. D’indole impetuosa, animato da un intransigente furore iconoclasta, Roger Nimier si gettò a capofitto nella vita, scegliendo di stare dalla parte sbagliata, quella che aveva appena perso, senza alcuna possibilità di rivincita, la sua battaglia. Di simpatie monarchiche, si era formato leggendo l’Action Française. Nel 1945, mentre la Francia era ancora in festa per la Liberazione, non ancora ventenne, corse ad arruolarsi nel 2° Reggimento Ussari e venne spedito di gran carriera negli Alti Pirenei. L’esilio durò meno di un anno, perché troppo forte era il richiamo della tenzone e, smobilitato, tornò a Parigi. L’unico agone praticabile rimaneva quello letterario, ben più vivace di quello ristagnante e compromissorio della politica. Al riguardo, Paul Morand non mancò mai di mettere in guardia il suo giovane amico: «Niente politica, perché tutto è perduto. Stattene tranquillo». Ma Nimier non era un tipo tranquillo, per lui «un uomo senza progetti è il nemico del genere umano».
A soli ventitré anni esordì presso Gallimard con il suo primo romanzo, Le spade, recentemente pubblicato in Italia, nella traduzione del curatore Massimo Raffaelli, grazie ad una piccola casa editrice padovana, Meridiano Zero. Il libro rappresentò un atto di sfida, una vera e propria dichiarazione di guerra ad un mondo culturale, quale quello francese del secondo dopoguerra, egemonizzato dalla sinistra, intento a tessere le lodi della Resistenza e ad esaltarne la superiorità etico-morale nel nome dell’incarnazione d’ideali indiscutibili. E non poteva esserci un’opera più aggressiva, sfrontata e controcorrente di Le spade, esatta antitesi del modello politicamente dominante di una letteratura ispirata dal dogma della responsabilità sociale dello scrittore. La storia, ambientata nella tumultuosa Parigi di quegli anni, è in buona parte autobiografica. La scrittura è asciutta e apparentemente trascurata, ma nello stesso tempo avvincente, ruvida nella sua sincerità, esplicita, veloce, cinematografica. Soprattutto è gettata sulla carta come una rapsodia, senza mediazioni stilistiche. E’ un lungo delirio nel quale il narratore non si preoccupa di analizzare gli avvenimenti che si susseguono, a coglierne qualche dettaglio, come se i fatti non dipendessero dalla sua stessa volontà e tutto fosse frutto di un copione già assegnato al protagonista, di una scelta già fatta. François Sanders si presenta nelle prime pagine come un ragazzino sensibile e annoiato, la cui attività principale consiste nell’annotare su un diario una minuziosa contabilità del suo onanismo. Vive un rapporto d’amore platonico, pur se progressivamente più sensuale, con la sorella Claude, che nella sottile e delicata ambiguità ricorda le vicende dei cugini René e Florence nel romanzo La ruota del tempo di Robert Brasillach (Edizioni Sette colori). Anche qui si avverte il timore del protagonista nei confronti di una maturità che sembra incombere come una minaccia, attirando su di sé la corruzione dell’ambiente esterno e determinando un fatale allontanamento dall’ideale di purezza insito nella gioventù e la fine della naturale complicità tra i due ragazzi. François inizialmente è attratto dalla Resistenza, ma rimane presto deluso dalla meschinità dei suoi compagni, che lo tradiscono e lui tradirà a sua volta. Il suo sguardo si rivolge altrove: «Nel ’44, Vichy mi rompe più che mai, ma i nazisti mi appassionano. Ho intuito la grandezza della catastrofe tedesca e gli ultimi sforzi del suo genio. Al confronto, i movimenti di resistenza mi parevano meritassero un semplice paragrafo nei manuali di storia. Vedevo in anticipo questo piccolo paragrafo, bianco e gelido, noto appena ai bravi allievi […] Non dubitavo della vittoria dei rossi. Loro portavano con sé la verità della storia – noi avremmo avuto la verità dei vinti, tanto più inebriante. In massa sentivo il nostro popolo rifluire verso i vincitori. E vedevo gli altri, i resistenti di giugno accoglierne le luride truppe a braccia aperte, adularle, adorarle». In una Parigi festante, «che scoppia di stupidità», uccide a caso tra la folla un ebreo, «solo per togliersi un capriccio», per eliminare quello che ritiene un «simbolo della nuova Francia, che mangerà a sazietà, lascerà cartacce sull’erba della domenica […] dunque, ho sparato su un simbolo […] Mi sono sottomesso all’ispirazione, ho sparato, ho sentito il dolce rinculo del calcio sulla spalla. Senza dubbio ho sussurrato: Uno di meno. Perché la buona educazione, che conta, dimostra che si può uccidere la gente senza essere comunque dei bruti». Passa tra le file della Milizia, insieme a «figli di papà in rotta con l’ideale, vecchi fascisti tubercolosi, bretoni amatori della Vandea e qualche pregiudicato – il sale della terra, come si dice». Sanders si trova più a suo agio con i duri. Forgia lui stesso un modo di chiamare Pétain, «vecchio culattone […] espressione che ha spopolato e di cui penso che la Milizia mi sia debitrice». La sua adesione al collaborazionismo è estetica, più che politica, è la sua personale reazione di fronte ad «un paese sprofondato nel disonore e con la vocazione al tradimento». «Più l’apocalisse si avvicinava alla Germania più essa diventava la mia patria […] la Germania, nel ’44, è stata il gran luogo di raduno dei desperados d’Europa. Tutta l’ebbrezza di una disfatta clamorosa e meritata si è presentata davanti a noi. I rossi non erano cattivi. Avevano l’innocenza pronta all’uso e tante altre cose. Noi li ammazzavamo e il buon Dio li accoglieva in paradiso. Mentre noialtri, il nostro Dio dei vinti ci offriva un altro piedistallo. Le notizie arrivavano dai quattro angoli del globo. Le disfatte si ammucchiavano davanti a noi per innalzarci, noi che mai avevamo goduto della vittoria».
Come scrive lo scrittore Eraldo Affinati nella prefazione all’edizione italiana, il collaborazionismo di Sanders-Nimier, che ne avrebbe segnato irrimediabilmente la vita come «un’indelebile cicatrice», consisteva soprattutto in una «faccenda di onore e giacche inamidate, fedeltà e sigarette, colpi sferrati a vuoto verso un nemico nascosto dove meno te l’aspetti». La scelta di arruolarsi era stata compiuta perché «non era facile avere vent’anni nel 1945». Affinati cita l’annotazione che Pierre Drieu La Rochelle aveva apposto sul suo diario: «ho collaborato per non essere altrove, nel gregge che trasudava odio e paura». Stato d’animo, più che motivazione razionale, che si adatta alla perfezione alla «rivolta solitaria» di Sanders, «giovane perduto» che «accarezza la Lüger nella tasca dei pantaloni», avuta da un ufficiale delle SS in cambio «di una boccetta di profumo». Se a Sanders non rimaneva altro che brandire la rivoltella, a Nimier non restava che impugnare la penna, anzi “la spada”. Nel romanzo scrive: «Ho sempre pensato che il mondo racchiuda un gran numero di spade segrete, e che ognuna sia puntata verso un petto […] e tutte quelle spade cercano in effetti un fodero di carne». Provocatorio ed irriverente com’era, dopo la pubblicazione del libro, indossò una piccola spilla a forma di spada e, per essere sicuro degli effetti delle sue insolenze, per irritare ancor di più i resistenti, lui, che era nato nel 1925 ed era ancora un giovane studente del liceo Pasteur negli anni dell’occupazione tedesca, pronunciava con noncuranza frasi come questa: «quando ero nelle Waffen SS…».
Quando lo scrittore Marcel Jouhandeau lesse il romanzo, raccontò che «fu come aver ricevuto uno schiaffo di gloria, di luce». Ed infatti Le spade riscosse un grande successo ed impose il giovane Nimier all’attenzione del mondo letterario parigino. Successo che si ripeté due anni dopo, con L’ussaro blu, romanzo che gli fece sfiorare la vittoria del prestigioso Prix Goncourt.
In pochi anni Nimier “sfoderò” un libro dietro l’altro, tra cui: Il grande di Spagna (1950, dedicato a Georges Bernanos), Perfido (1950), Bambini tristi (1951, tradotto da Alfredo Cattabiani venne pubblicato in Italia nel 1964 per le Edizioni dell’Albero), Storia di un amore (1953, l’edizione italiana, sempre a cura di Longanesi, è del 1962) e, dopo un lungo periodo di inattività («una specie di voto», disse a François Billetdoux), D’Artagnan innamorato ovvero cinque anni prima (l’omaggio a Dumas era ormai in tipografia quando Nimier morì tragicamente e l’opera uscì postuma, pochi mesi dopo la sua morte, mentre in Italia Longanesi la pubblicò nel 1964).
Nimier non si limitò ad esercitare il mestiere di narratore, come direttore editoriale di Gallimard si sentiva in dovere di lottare per riabilitare chi non c’era più, chi non era sopravvissuto, perché era morto o perché, per aver condiviso le sue stesse idee, era stato rimosso, esiliato in un limbo letterario.
Giuseppe Scaraffia, tra i pochi conoscitori italiani di Nimier, ha scritto che «indifferente all’ostracismo della sinistra, rintracciò la sua parentela dispersa dalle epurazioni letterarie». Pubblicò autori dimenticati, come Morand, lo stesso Jouhandeau e Céline, di cui divenne consigliere ed amico, sino ad essere tra i pochi intimi cui fu concesso di accompagnarne le esequie.
Nimier fu anche un brillante critico e polemista, dalle colonne de Opéra, La Table Ronde, La Parisienne e Arts, uno dei più prestigiosi settimanali culturali dell’epoca, e un convincente sceneggiatore cinematografico (firmò, tra l’altro, uno dei tre episodi del film I vinti di Michelangelo Antonioni e, insieme all’amico Louis Malle, Ascensore per il patibolo).
Ma soprattutto fu l’animatore e il capofila di un battaglione di scrittori-intellettuali (tra i quali Jacques Laurent, Michel Déon e Antoine Blondin) che si opponeva aspramente a chi spadroneggiava nel mondo culturale e nelle case editrici, di una vera e propria “fronda” che rifiutava il romanzo esistenzialista, il settarismo e il moralismo del detestato engagement culturale francese, dominato dalla ingombrante presenza di due maître a penser come Sartre e Camus. Fu Bernard Frank, giovane giornalista che in seguito diventerà un affermato opinionista al Nouvel Observateur, a definirli per la prima volta “gli ussari”, in un articolo, Hussard e grognard, pubblicato nel dicembre 1952 su Les Temps modernes, la rivista-partito di Sartre, non pensando di battezzare così una scuola letteraria. Il termine voleva esprimere la loro vivacità, la combattività e persino l’abbigliamento, austero, quasi militare, del leader carismatico del gruppo, Nimier. La loro scrittura disinvolta era tesa a demolire la pretenziosità e la pesantezza dei letterati impegnati. Nelle loro opere gli ussari esprimevano un dichiarato rifiuto del mito della Resistenza e della sua ideologia. Atteggiamento, questo, che gli valse la fama subito di “fascisti”. Didier Sénécal, nel suo Roger Nimier à la tete des hussards (Lire, mars 1999), spiega: «Per il capo incontrastato degli ussari l’obiettivo è semplice: scandalizzare i benpensanti di sinistra e le tre principali componenti di quella intellighentia: gli stalinisti, i sartriani e i lettori de Le Monde. Il suo impegno è quello di rimettere in sella i grandi epurati della liberazione. Gli innocenti, come Jean Giono o Marcel Aymé, ma anche i colpevoli, come Jouhandeau, Chardonne e Céline».
A 37 anni Nimier aveva già raccolto una ricca collezione di nemici. Del resto possedeva tutte le qualità per attirare l’invidia di colleghi ed avversari: era bello, centottantaquattro centimetri di fascino e di muscoli coltivati con la pratica del rugby e della boxe («sono attratto dal sudore e dal sangue, dalla gratuità della cosa. E potermi battere realmente mi sembra stupendo»), era borghese e voluttuosamente mondano, sempre impeccabilmente curato ed elegante, distaccato e ostentatamente cinico, come a segnare ogni volta un preciso quanto invalicabile confine tra lui e il mondo.
Amava girare a bordo delle sue luccicanti auto sportive, con la capote vezzosamente abbassata anche in pieno inverno e un bagaglio essenziale sempre a portata di mano: un pigiama, un rasoio e i volumi del Littré, il più raffinato dizionario di francese. Morand, che pure ne condivideva la passione per le auto di grandi cilindrata, gli ripeteva spesso: «Ti rimprovereranno la Jaguar per tutta la vita, il che è ottimo. Dimenticheranno perfino la tua bellezza e il tuo talento, ma la Jaguar mai».
E fu proprio la sua ultima fuoriserie a tradirlo, in una sera d’autunno. Nonostante l’approssimarsi dell’oscurità, uscendo da Parigi sulla sua Aston Martin DB4, lanciata «a plus de 150 à l’heure», si schiantò contro il parapetto di un ponte del raccordo ovest di Parigi. Nel necrologio che gli dedicò due giorni dopo il Journal du dimanche l’articolista si sentì in dovere di ricordare che lo scrittore «aveva avuto una Jaguar e una Delahaye» e di sottolineare come «le sue vetture erano i suoi giochi preferiti e ne scriveva lungamente nelle sue opere». Infine ricordò che «in uno dei suoi libri aveva già descritto un incidente d’auto mortale». Nel romanzo Bambini tristi, infatti, il suo alter ego, Olivier Malentraide, trova la morte in una circostanza singolarmente analoga: «Olivier spinse la macchina ai 130, passando semafori rossi, evitando al pelo i camion ed i ciclisti. Dopo aver corso per qualche minuto a quella velocità, trovò quel che era venuto a cercare in un grande cantiere dove avevano scavato delle buche profonde…». Accanto a Nimier morì la bellia scrittrice Suzy Durupt, 27 anni, che con lo pseudonimo di Sunsiaré de Larcòn aveva pubblicato con Gallimard, grazie a Nimier, il suo primo ed unico romanzo. «Ha sedotto la morte come le ha sedotte tutte» scrisse Morand.
Ed è con questa uscita di scena improvvisa e violenta che è terminata la corsa di uno de Gli Ultimi dandies (Sellerio 2002), famiglia nella quale l’autore del libro, Scaraffia, colloca a pieno titolo Nimier, racchiudendo in poche righe l’essenza della vicenda umana e artistica di Nimier: «il dandy cerca invano nel volto dei vinti un’eco delle virtù che ama: il distacco degli interessi, l’ebrezza di essere in minoranza, il gusto dell’azzardo e del gioco sempre più stretto con la morte». Sempre per rimanere alle definizioni, specialmente quando sono appropriate, come ha scritto Maurizio Serra ne L’esteta armato (Il Mulino 1991), Nimier era «l’ultimo erede degli esteti armati […] i condottieri del Bello e insieme dell’Azione […] l’aristocrazia sensuale e guerriera che nella civiltà europea degli anni Trenta teorizzò una rivolta contro la decadenza».
Con la sua prematura scomparsa, i “moschettieri”, gli ussari, si sono dispersi nel disimpegno. Nelle librerie francesi sono continuati ad arrivare, postumi, altri libri di Nimier, a testimonianza di una vitalità che non poteva essere contenuta in una vita così breve, anche se intensa.
Nel 1968, con la prefazione dell’amico Paul Morand, quasi a restituire un affettuoso favore e a saldare un debito di riconoscenza, viene pubblicato il romanzo che Nimier aveva scritto ventenne e che era stato rifiutato dalle case editrici, Lo straniero, e altre opere, come Il trattato d’indifferenza, un pamphlet filosofico che raccoglie otto riflessioni scritte negli anni Cinquanta da un cinico che era ben consapevole che «non c’è cinismo senza sentimento», pagine che ci piacerebbe poter leggere presto in italiano. Chi ha orecchie per intendere, chi per passione o mestiere fa l’editore, intenda.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Roberto ALFATTI APPETITI:
Roberto ALFATTI APPETITI: Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.
Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”. En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.
En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.